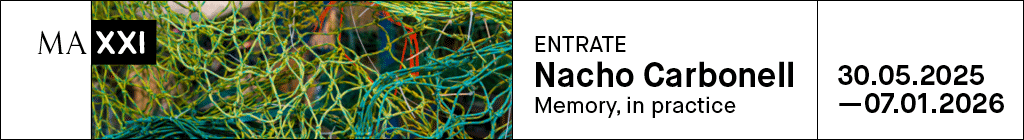Immaginiamo che i suoi committenti la preghino di non progettare scatole.
Assolutamente sì: i miei committenti mi richiedono un linguaggio. Larchitettura dei musei contemporanei deve anche disturbare; lidea dovrebbe essere radicale. I direttori dei musei e i loro curatori non vogliono spazi regolari, hanno necessità di mostrare la varietà dellarte contemporanea e rispondere alleterogeneità comporta la costruzione di spazi fluidi, da abitare e da scoprire progressivamente (pensate al Guggenheim di New York). Daltra parte il landscape è esattamente come larte contemporanea, costruito. Anche in Lituania (nel museo Hermitage-Guggenheim che sto realizzando a Vilnius), il rapporto che cerco tra il tema del museo e il paesaggio, non può prescindere dallo scoprire i mondi che possediamo nella mente, perché il paesaggio non è fisico ma mentale. Soprattutto per un museo litinerario si configura come un viaggio mentale sollecitato da impulsi sensoriali.
Tra il 1986 e il 1989 ha fondato e diretto a Milano un laboratorio didattico di progettazione, «Architecture Intermondium». Il soggiorno milanese le dà modo di frequentare larchitetto italiano Aldo Rossi che lui stesso ha poi definito «partner di un dialogo silenzioso». Però allinizio degli anni novanta lei scappa da questo paese («un paese che amo ma dove non è possibile fare architettura», disse) e va a lavorare come senior scholar per la Paul Getty Foundation.
Tra il 1989 e il 1990 è cambiato qualcosa nel mondo dellarchitettura, non solo in Italia. Credo di aver incontrato per la prima volta Aldo Rossi a New York. Ho trascorso con lui notti e giorni interi: ci ha legati lidea che larchitettura sia molto di più di quanto appare (linguaggio e disegno per esempio).
Da qualche anno è ritornato a Milano, una città tra le prime cinque al mondo per numero di musei. Feudo di Salvatore Ligresti, City Life è il più grande intervento di riqualificazione della città: con la sua torre curva (a destinazione per ora mista, residenziale e alberghiera) e soprattutto con il Museo di arte contemporanea (Mac), sarà un punto importante per la ricandidatura dellattuale amministrazione?
City Life, ovvero la riqualificazione della sede storica dellex Fiera campionaria, è un progetto centrale per Milano, per posizione e funzioni: residenza, lavoro, cultura con il Mac. Quello dei musei non è un problema di numeri ma di forza mediatica: Milano ha musei in quantità, artisti e ottimi designer, ma non ha un luogo che li rappresenta.
Gli anni novanta sono stati anni di musei; e quelli progettati da lei non sono pochi: Museo ebraico a Berlino (1989-1999), Casa Felix Nussbaum a Osnabrück (1995-1999), Danish Jewish Museum di Copenaghen (1996- 2003), Imperial War Museum di Manchester (1997-2002), Denver Art Museum (2000-2006), Royal Ontario Museum a Toronto ( 2002-2007). Ma lei è ancora di più un architetto di memorials: il simbolismo delle sue opere, le fa percepire come monumenti della memoria.
È vero, perché per me il museo è memoria (altrimenti diventa solo un altro museo): necessita di memoria come dei materiali di cui è fatto. Mi piace lavorare sullinterpretazione della memoria (come Giordano Bruno con le sue «immagini aggiunte» nellArs memoriae) per rappresentarne i diversi tipi.
Gli interni dei suoi musei sono spazi che parlano se lasciati vuoti. Lallestimento, soprattutto laddove sono esposti oggetti che impongono un percorso narrativo, è spesso percepito come unazione aggiunta, che non riesce a integrarsi alla composizione architettonica.
Non mi occupo dellallestimento. È una disciplina che è cambiata moltissimo in questi ultimi decenni. Penso che ci si debba distaccare dal progetto architettonico e guardare allallestimento come a un insieme di dispositivi destinati a mutare nel corso del tempo. Al Guggenheim di New York ci sono voluti molti anni prima che si mettessero in discussione gli allestimenti di Frank Lloyd Wright. A volte è opportuno estraniarsi e riflettere su cosa sia meglio cambiare.
Quando siniziava a pensare alla Pechino olimpica lei disse: «Non costruiamo a Pechino perché non progettiamo per i regimi».
Sì, ma i dittatori cambiano e i sistemi non sono nè bianchi nè neri. Limportante è fare unarchitettura dove le persone possano partecipare sempre più numerose, alla costruzione, nello spazio (per questo non può mancare una big lobby allingresso in un museo contemporaneo). Larchitettura dei regimi è piena di errori proprio perchè non è il frutto di opinioni e punti di vista differenti tra loro. E i musei in particolare, nellepoca del capitalismo, dovrebbero, oltre a rendere economicamente, generare opinioni e interpretazioni diverse, visioni future. Larchitettura deve ancora conquistare la sua autonomia dai governi: solo così in futuro potremo leggerla.
Lei dunque invita il mondo dellarchitettura a emanciparsi dai governi ma poi si occupa soprattutto di musei, che dovrebbero essere gli emblemi del potere istituzionale.
Dalla fine degli anni ottanta, il trauma rimane il centro della mia opera, come si può capire anche dallampliamento del Museo di storia militare che sto seguendo a Dresda. Certo, per trauma, non intendo solo il vuoto generato dai genocidi e dalle distruzioni, ma un momento di presa di coscienza rispetto a qualcosa che non è possibile comunicare esplicitamente.
Gli interventi di ampliamento recenti costituiscono un aspetto centrale della museografia contemporanea. Quali sinergie sinnestano nella ricerca di un dialogo con i maestri? A Denver, per esempio, quale relazione sinstaura tra la cortina ermetica progettata da Gio Ponti e lesplosione volumetrica della nuova sede dellArt Museum?
Le architetture di Ponti sono state molto importanti nella mia formazione, soprattutto durante i soggiorni a Milano, dove si avverte leco della sua esperienza in molti brani della città. Lintervento di Ponti per il Denver Art Museum è tuttora considerato molto radicale nel paesaggio architettonico americano. Non si vedono architetture simili a New York o a Chicago. Ho ascoltato lopera di Ponti, e come lui ho subìto il fascino delle Rocky Mountains cercando, nelle aperture a feritoia e nello studio di rapporti luministici del titanio, un dialogo con la sua parete-fortezza cangiante.