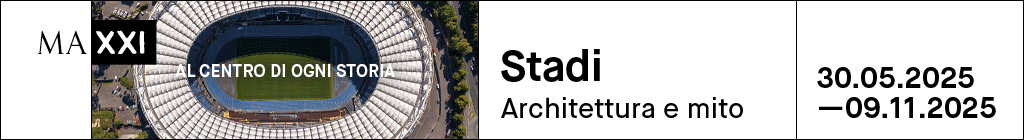Firenze. Il 6 maggio Alvaro Siza ha ricevuto a Palazzo Vecchio dal vicesindaco Dario Nardella le chiavi della città. Levento è stato curato dalla Fondazione Targetti in collaborazione con lassociazione A as Architecture.
Lei è considerato un maestro del disegno. Ma fino a che punto i suoi disegni sono in rapporto con gli edifici costruiti, con quello che avviene in cantiere? Hanno una porzione di autonomia rispetto allarchitettura oppure ogni linea si traduce in qualcosa di tangibile?
Il disegno è innanzitutto uno strumento, ed è il migliore a disposizione dellarchitetto per fare dei test su quello che sta progettando. È per questo che io molto spesso faccio schizzi su piante e sezioni. Non solo: nelliter progettuale il disegno è un momento in cui si possono scoprire nuove aperture, nuove soluzioni a problemi specifici. Alvar Aalto, in un piccolo testo bellissimo, descrive come il progetto possa entrare in crisi in determinati momenti, e come sia proprio allora che sente la necessità di disegnare, per uscire dallempasse. Tuttavia, a volte il disegno è autonomo. Io disegno per piacere, per relax. In unattività dura come è quella dellarchitetto è facile entrare in crisi ed è allora che il disegno viene in soccorso.
Magari per risolvere un dettaglio? Quanto contano i dettagli nella sua architettura?
Innanzitutto il dettaglio è necessario perché ha a che fare con la tecnica e con tutte le normative che vi stanno a monte. Pensiamo a tutti i dettagli che discendono dalle norme sul ricambio daria piuttosto che sulla sicurezza antincendio: griglie di aerazione, estintori, bocchettoni per i vigili del fuoco
Sono tutti dettagli che disturbano. Un dettaglio ben fatto, al contrario, toglie confusione dal momento che è concepito non per attirare lattenzione ma per prendere il suo posto nellinsieme.
Siza come Scarpa?
No, non è Carlo Scarpa, anche se i suoi dettagli sono preziosi. Il fatto però è che Scarpa arrivava a padroneggiare i dettagli dialogando con gli artigiani che materialmente li eseguivano.
Però lei ha raccontato molte volte quellaneddoto sul cantiere del complesso residenziale Bonjour Tristesse a Berlino, per lIba del 1984: il posatore delle piastrelle vuole metterle in un modo «perché a Berlino si fa così», lei lo convince a metterle come da progetto.
Sì, certo. Devo aggiungere che il giorno dopo mi chiamò lingegnere direttore dei lavori. Era furibondo perché avevo parlato con un operaio, violando quindi la gerarchia di un cantiere organizzato rigidamente. Aggiungo questa appendice allaneddoto perché ne emerge con chiarezza un problema largamente presente nellarchitettura: il fatto che la filiera sia sempre più lunga, che ci sia sempre più distanza tra chi fa e chi pensa. Oggi larchitetto deve essere competente sulle norme, non sulle tecniche di cantiere; e questo è un male.
Una questione dibattuta è il suo ruolo nella formazione di almeno una generazione di architetti in Portogallo. Nellarchitettura italiana del secondo Novecento il rapporto del maestro con gli allievi si è spesso tradotto in unaffinità anche formale. A Rossi piacevano molto i rossiani…
Quelli che hanno lavorato con me non mi imitano. Faccio lesempio di Eduardo Souto de Moura. Quando abbiamo progettato insieme il padiglione della Serpentine a Londra, tutti mi dicevano di non riconoscermi, che si vedeva solo Souto
a lui dicevano lopposto. Del resto se si lavora insieme lo si fa per avere dei risultati diversi dal solito, almeno sul piano del linguaggio. Per quanto riguarda limitazione in generale, riferita alla didattica di architettura, credo che la situazione degli studenti che adesso frequentano i primi anni sia davvero molto diversa da quella che ho vissuto io. Ora internet mette a disposizione una quantità incredibile dimmagini e riferimenti. Ai miei tempi cera ben poco a disposizione, così abbiamo prima assimilato Le Corbusier, poi i brasiliani, poi Aalto. In fondo è sempre stato così: tutto quello che facciamo come architetti lo abbiamo visto in giro, ma se abbiamo avuto una corretta formazione da architetti, siamo in grado di non produrre delle copie.
Ma allora esiste la «scuola» di Porto?
La scuola di Porto esisteva negli anni cinquanta e sessanta. Esisteva perché la facoltà era piccola e isolata, di conseguenza con un elevato grado di interazione tra tutti. Ora i numeri sono cambiati molto e non si può parlare di un ambiente unitario, mentre gli anni cinquanta hanno rappresentato a Porto un momento di coesione. A tenere insieme le fila di tutto è stato un personaggio come Fernando Tavora, che godeva di un prestigio generalizzato, tanto che da Lisbona, città del regime, diversi architetti dissidenti si spostarono a Porto.
I suoi progetti per ledilizia pubblica degli anni settanta sono stati letti anche molto in chiave politica. Ha senso dire che a una certa architettura corrisponde un certo significato politico?
Si, però non esiste unarchitettura rivoluzionaria. Quando alla metà degli anni settanta, dopo la rivoluzione, portammo avanti lesperienza con il Saal (Serviço ambulatório de apoio local, un servizio pubblico decentrato per il miglioramento delle condizioni di vita nelle aree disagiate, fortemente orientato alla partecipazione degli utenti, istituito dopo la rivoluzione dellaprile 1974, ndr), realizzai subito che il cambiamento era nel modo di organizzare il lavoro, non certo nella mia concezione dellarchitettura. Alcuni obiettavano che fino ad allora avevo progettato solo case borghesi, che non avevo mai avuto clienti tra la classe operaia e gli stessi utenti del Saal consideravano gli architetti come dei borghesi, pertanto ne diffidavano. Le discussioni erano dure, ma alla fine gli architetti che rinunciavano alle loro prerogative disciplinari si sentivano richiamare dagli stessi utenti: «bene, architetti, abbiamo discusso per tanto tempo, ora portateci i disegni!». Ecco si torna al tema del disegno
io non ho mai rinunciato a disegnare. Ai tempi del Saal alcuni architetti dicevano «io sono la mano del popolo». Non che ritenessi secondario parlare con gli utenti dellarchitettura, ma questo avviene sempre, anche nelle commesse per le case borghesi ovviamente.
Negli anni ottanta cè chi è arrivato a dire che la partecipazione è la svendita del progetto
La partecipazione come metodo, ma anche come parola dordine, è stata una risposta alla crisi dellarchitettura durante gli anni settanta. Premesso che probabilmente larchitettura è sempre in crisi, si era arrivati a uno scollamento troppo grande tra architettura e realtà; ci voleva una reazione e quella fu individuata nella partecipazione. Poi comunque noi a Porto, nel 1974, ci trovammo subito di fronte a una situazione decisamente emergenziale, per cui non cera troppo tempo per riflessioni teoriche su cosa volesse dire partecipazione. Il centro della città aveva una densità spaventosa. Fin da inizio Novecento gli isolati borghesi erano stati saturati al loro interno di case per le classi povere, alloggi piccoli e fatiscenti, con una crescita interamente basata sulla densificazione e non sullespansione attraverso nuovi quartieri. Fin da subito dopo la rivoluzione i poveri del centro di Porto si organizzarono in cooperative per la costruzione di case. Anche se i rapporti con gli architetti – lo ripeto – erano molto conflittuali, noi eravamo nella partita e fummo criticati [da altri architetti] per esempio perché di fronte allemergenza puntavamo molto sulla rapidità dintervento, occupavamo lotti vacanti per costruirli prima che fossero destinati ad altri usi. Altri sostenevano che prima era necessario educare la classe povera alla cultura dellabitare, che noi stavamo andando troppo in fretta. Fu così che dallabitazione la discussione si spostò sulla città, alla cui dimensione ormai ci stavamo muovendo.
Allora la partecipazione come vettore con cui passare da una scala allaltra, da quella architettonica a quella urbana? Ma anche per passare da un paese a un altro, come un tappeto volante?
La partecipazione può anche essere un «trucco», una cosa ambigua. Non sto dicendo che lesperienza del Saal sia stata tutta positiva. In ogni caso ebbe molta eco. Gli incarichi a Berlino e allAia sono venuti grazie al Saal e devo dire che, soprattutto allAia, cè stata vera partecipazione. Lì infatti il lavoro progettuale è stato preceduto da un lavoro so ciale approfondito, sul campo, fatto da specialisti. Erano i primi anni ottanta ma la zona dove è collocato lintervento già presentava evidenti problemi di convivenza tra abitanti con origini molto diverse: arabi, olandesi, cinesi. Gli olandesi tacciavano i cinesi di sporcizia perché compivano tutte le loro attività in casa, al chiuso, anche i piccoli lavori extradomestici; gli arabi accusavano gli olandesi di essere sporchi perché abitavano in case con un solo piccolo bagno; a loro volta gli arabi avevano unidea del tutto diversa della privacy, legata alla loro concezione del ruolo femminile. Lamministrazione locale mi chiese di progettare una casa adatta agli olandesi, una agli arabi, una ai cinesi e dincastrarle insieme. Io risposi che stavano sbagliando completamente obiettivo e mi misi al lavoro su una casa che andasse bene per tutti, in cui tutti si potessero riconoscere. Per esempio, per venire incontro allesigenza degli arabi di avere locali separati per le donne quando avevano ospiti in casa, disegnai una distribuzione con un doppio corridoio, separato da porte scorrevoli. Una soluzione che, se andava incontro alla concezione del ruolo della donna nella famiglia musulmana, al tempo stesso venne gradita dagli olandesi per la sua flessibilità, perché consentiva di ottenere una zona giorno più grande. Venni anche attaccato per aver accettato di disegnare gli alloggi sulla base di una tradizione di segregazione della donna, ma ero convinto che nellimmediato bisognasse venire incontro a tutti attraverso larchitettura stessa, e che comunque nel giro di un paio di generazioni le usanze sarebbero cambiate e quegli spazi sarebbero stati usati da tutti nella stessa maniera. Invece poi
le cose sappiamo bene come stanno andando; il processo dintegrazione si è bloccato. Io in ogni caso continuo a non capire, per esempio, il divieto dindossare il burqa in pubblico. E per quanto concerne il mio quartiere allAia, sottolineo che oggi non è degradato, le case sono ben tenute e non ci sono tensioni sociali o etniche.
Negli anni settanta nelledilizia pubblica partecipazione era un termine quasi ubiquo, ora cè leco-housing
Credo che sia in parte una moda e in parte unopportunità, anche se la situazione attuale è piena di contraddizioni. Faccio un esempio fuori dal settore residenziale: in Portogallo un albergo a 4 o 5 stelle deve avere laria condizionata, quando con gli opportuni accorgimenti nel nord del paese si potrebbe benissimo farne a meno. Al tempo stesso sono richiesti dei livelli disolamento dellinvolucro che renderebbero superfluo il condizionamento estivo. Le normative hanno preso la forma di una paranoia.