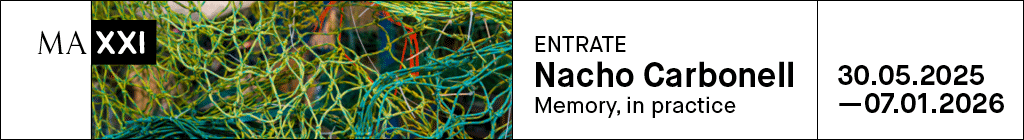A dicembre del 2008 il critico darchitettura del «New York Times» Nicolai Ouroussoff ha aperto così la sua rubrica settimanale: «Chi avrebbe mai immaginato, un anno fa, che ci stavamo avvicinando alla fine di una delle epoche più deliranti della storia dellarchitettura moderna?» (cfr. Ma è stato bello (finché sono durati i soldi), in «Il Magazine dellArchitettura», n.17, febbraio 2009). Per la stragrande maggioranza dei professionisti dellarchitettura e delledilizia, questepoca finita molto tempo fa. È come se il «New York Times» fosse stato lultimo a pronunciare lelogio a un funerale già concluso. Il punto è che da un po si è creata una spaccatura nella professione. Se una parte ha ampliato i confini delledilizia, un gruppo nuovo e più giovane ha cominciato a chiedersi perché e per chi costruiamo. Ad aprile Architecture for Humanity ha compiuto dieci anni e ci ha sorpreso constatare che la nostra rete conta oltre 40.000 professionisti, la maggior parte dei quali appartiene al nuovo gruppo. Siamo arrivati al punto in cui larchitettura degli eccessi e quella della sostanza sono destinate a scontrarsi. Vista la crisi, io so da che parte starò. Perché? Facciamo un passo indietro. Nel mondo, una persona su sette vive in insediamenti non pianificati, favelas, campi profughi o campi di sfollati. Quasi cinque miliardi di persone vivono in condizioni inadeguate e hanno accesso limitato a istruzione, sanità e igiene. Quasi nessuna di queste comunità utilizza i servizi dei professionisti dellarchitettura. Chi di noi lavora in questa arena è subissato di richieste daiuto a partire dai campi del Congo orientale fino ad arrivare alle baraccopoli della California del sud. Cè un enorme desiderio di strutture ben costruite e sostenibili, e i giovani professionisti a caccia di significato si ritrovano a offrire la loro competenza a tali comunità. Gli architetti hanno la grande opportunità di lavorare al servizio dellumanità invece che di cercare goffamente di definirla o, peggio, di imporle una soluzione. Ieri avrei dovuto parlare con Zaha Hadid delletica dellarchitettura al Barbican di Londra. Ho affrontato un viaggio, per farlo, e poco prima che il dibattito iniziasse lho immaginato come una sorta dincontro di pugilato tra Alì e Foreman sul ruolo dellarchitetto nellambiente edificato e su come noi, in quanto professione, possiamo agire e reagire allattuale crisi economica. Nei circoli dellélite culturale so di trovarmi su un terreno minato. Se Hadid ha di certo avuto un impatto durevole sul discorso architettonico, alcune sue strutture si sono rivelate deboli dal punto di vista ambientale, di natura esclusiva e a volte dubbie dal punto di vista etico. Sgomitano per richiamare lattenzione, perforano il tessuto urbano invece di inserirsi in esso trasformandolo in un ambiente più forte e più omogeneo. Quanto al dibattito, ma cera da aspettarselo, Hadid si è ritirata e ha mandato un sostituto. Proprio come lincontro tra Alì e Foreman, anche il nostro faccia a faccia è stato rinviato. Il dibattito in sé non è stato specifico come avrebbe potuto, soprattutto perché il gruppo di invitati si è chiesto cosè un «buona architettura», cosè «letica», cosa significa «cambiare il mondo». Non che sia stato un male. Eravamo evidentemente molto lontani dallaccettare la piega del dibattito, ma sono comunque emersi cinque punti di vista diversi, tutti validi. Io sono rimasto sorpreso nel notare quante presentazioni avessero immagini senza persone né edifici. Era ovvio che la maggior parte dei membri del gruppo fosse più interessata alletica individuale (persino alla moralità) che a quella collettiva. Il tema ruotava attorno al modo in cui ciascuno vede se stesso in una data situazione e non al modo in cui vede la professione e la sua capacità di adattarsi agli attuali cambiamenti di ambiente, politica, economia o cultura. Ho avuto limpressione che i costanti rimandi alla morale e alla moralità fossero più che altro un diversivo, per quanto interessante da discutere. A questo livello, è una sfida individuale quotidiana per noi, specie per chi deve decidere se accettare un lavoro tuttaltro che desiderabile per mantenere a galla lo studio. Il commento di Frances Anderton (cfr. Excess Versus Relevance Is an Irrelevant Debate, in «The Huffington Post», 10 aprile 2009), secondo il quale il dibattito è irrilevante perché si tratta di una questione ben definita, però, è errato. Certo, come Hadid fa notare chiaramente, molti «grossi nomi» dellarchitettura hanno realizzato opere socialmente responsabili, anche se molte di meno rispetto a quelle del campo medico o legale. Il dibattito non riguarda tanto la sostituzione di un «ismo» con un altro, quanto lanalisi di cosa accade nel vuoto lasciato dalla crisi economica globale. Gli architetti si rivolgono soltanto a clienti superricchi o diventano più teorici mentre superano la crisi oppure la professione può espandersi in ambiti più rilevanti per il clima attuale? Il tema non è mai stato archistar contro non archistar, ma come ci adattiamo e cambiamo in quanto gruppo di professionisti dediti a migliorare lambiente fisico che chiamiamo vita. Non esiste l«architettura con la A maiuscola», esiste solo larchitettura, e il modo in cui la pratichiamo conta non solo per lo stato del mondo, ma anche per la sopravvivenza della stessa professione.
The Architects Dilemma: The Architecture of Excess vs. an Architecture of Relevance, in THE HUFFINGTON POST, 10 aprile 2009