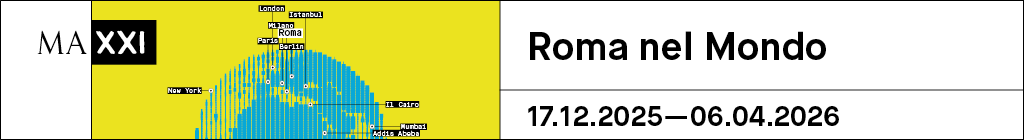La lunga carriera, il sodalizio con la moglie Denise Scott Brown, l’interpretazione del popolare e della società americana, tra registri alti e bassi, tra immagini e icone. Sempre con ironia
Se si potesse scegliere un unico disegno per riassumere l’arco di una vita lunga quasi un secolo ma che ne ha abbracciati due, di Robert Charles Venturi jr. dice più di ogni altro il piccolo “I am a monument” al tratto, pubblicato nel 1972 come figura 139 di Learning from Las Vegas, il suo – e di Denise Scott Brown [con lui nella foto di copertina], compagna di vita e di ricerca dal 1964 – secondo libro manifesto dopo la mite ma dirompente iconoclastia del “less is a bore“ di Complexity and Contradictions del 1966. Il segno che impara dalla sintesi dei comics, l’intrinseca contraddittorietà di testo e disegno – è evidente che la scatola appena definita dalle finestre accennate non è un monumento – perfino il fatto che a dire “I am” sia l’edificio stesso: l’interesse per l’espressione popolare e vernacolare, il gusto per le contraddizioni, la rinuncia all’autorità in nome del pluralismo.
Riduttivamente ascritto a iniziatore del postmoderno, più volte nella sua carriera Venturi – nonostante la consacrazione internazionale giunta nel 1991 con il Pritzker Prize – fu accusato di populismo: parola lanciata come una pietra nei dibattiti accesi che seguirono ad esempio il suo incarico per la Sainsbury Wing della National Gallery di Londra, inaugurata nel 1991 dopo l’abbandono di un precedente progetto high tech. Il peso di questa pietra allora poteva apparire ancora leggero strumento di conflitto tra intellettuali, ma un’occhiata su Youtube ad un video postato dall’UKIP nella campagna elettorale locale del 2013 – in cui il modernismo ortodosso dell’architettura pubblica inglese e la tecnofilia dell’architettura commerciale della City diventano emblemi della distanza tra le élite e il popolo, tra globalisti e i veri Britons – ci permette di misurare la durezza dell’accusa, e insieme la durevolezza della questione: a chi parla l’architettura? Di chi parla l’architettura?
Proprio nei tempi di populismo imperante che con sorpresa oggi ci troviamo ad attraversare, appare preziosa l’apertura di Venturi a quanto accade fuori del mainstream dell’
Il riferimento all’ottimismo con cui la Pop Art incorporava nell’avanguardia i codici della comunicazione di massa operandone al contempo il détournement attraverso dispositivi come la stilizzazione, l’iterazione, il salto di scala, la citazione – gli stessi dispositivi attraverso cui fin dal piccolo progetto per la casa materna del 1961 tesse un disincantato dialogo con la grande storia dell’architettura classica e la tradizione minore dell’America vernacolare – colloca Venturi nella prospettiva positiva di un’America kennediana in cui la spinta al futuro attraversa e unifica le diverse anime di una società plurale e conflittuale ma in fondo coesa. Emblematico di questo atteggiamento il suo bill-board-building per la National Baseball League Hall of Fame del 1967, mai realizzato, in cui la celebrazione di un culto sportivo nazionale viene affidata ad un elemento iconico della suburbia come lo schermo del drive-in, giustapposto ad un più schematico corpo di fabbrica con la stessa brutale semplicità con cui l’insegna sta sopra l’auto-proclamato monumento, o i segni della strip di Las Vegas ne scandiscono il paesaggio urbano.
Il popolare non viene esaltato, viene incorporato e reinventato: ma questa continua inclusione/distinzione mantiene aperta la possibilità di un dialogo non giudicante tra alto e basso che consente diversi livelli di fruizione e comprensione di un’architettura che si vuole sempre parlante, mai silenziosamente sottratta al dialogo pluralista della città, dello spazio pubblico, della democrazia. Con lo stesso sottilmente ambiguo aderire e distanziarsi nell’ultima parte della sua carriera, Venturi – ma va detto che il sodalizio con Scott Brown ha una profondità tale che le polemiche per l’attribuzione a lui solo del Pritzker per un’opera furono più che giustificate, e tutt’ora rinviano alla questione aperta di una nostra troppo individualista idea di autorialità – apre con curiosità alle possibilità offerte dalle nuove tecnologie d’introdurre in forma dinamica elementi discorsivi – alcune delle sue pagine come dei suoi progetti migliori sono dedicati alle parole scritte sugli edifici, come modo esemplare di rendere evidente il senso collettivo scolpendolo nella pietra dell’architettura pubblica – come negli schermi del progetto di concorso del 1995 per la nuova ambasciata americana alla porta di Brandeburgo a Berlino, in cui l’architettura si riduce ad un generico muro – letterale trascrizione di norme stringenti di sicurezza – da cui i passanti possono gettare l’occhio attraverso il taglio dell’ingresso sul racconto visivo in movimento e sempre rinnovato di un’America quotidiana, moltiplicato all’interno da onnipresenti schermi video. Certo non un monumento, ma comunque una celebrazione affettuosa ma non condiscendente di un mondo di vita troppo a lungo ignorato, la cui rabbia scuote oggi le nostre democrazie.