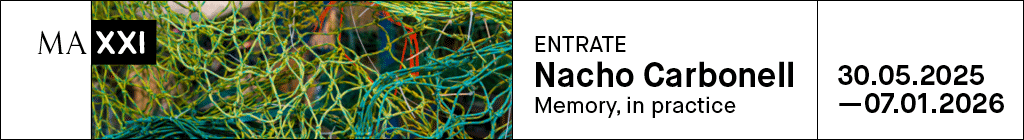Nella confusione di competenze e di figure professionali che fanno riferimento alla progettazione e, soprattutto, in considerazione dellabnorme numero di professionisti che vi si dedicano in Italia, caso patologicamente unico nel mondo, prima di sviluppare qualsiasi ragionamento sul tipo di preparazione che bisognerebbe assicurare agli architetti, in formazione o in attività, occorre domandarsi se oggi si deve chiedere alle università di insegnare ai giovani perché «imparino il mestiere» o per dar loro una cultura meno orientata. In altre parole, se le lauree devono essere professionalizzanti o invece volte a soddisfare attitudini e bisogni intellettuali più indefiniti. Certo, i problemi degli architetti e delle facoltà di Architettura non sono uguali a quelli di altri corsi di studio, quindi ogni ragionamento va calato specificamente in questo contesto e può portare a soluzioni del tutto differenti da quelle adottabili per altri ambiti formativi. È probabile, comunque, che qualsiasi ipotesi di preparazione non indirizzata alla professione e rivolta a unacculturazione genericamente umanistico-scientifica farà correre il rischio di un depotenziamento del valore del titolo di studio universitario, fino alla completa abolizione del suo valore legale (come da tempo una potenza economica qual è la Confindustria chiede). Facendo peraltro tornare lUniversità – come un tempo di cui non si ha più nostalgia – unarea, pur privilegiata, di parcheggio, in attesa di un sempre più lento e difficile inserimento nel mercato.
Oggi invece, più che mai, i tempi di crisi globale impongono integrazione tra didattica e mondo del lavoro. Piuttosto, cè da chiedersi se sia stato migliore il lungo periodo in cui vigeva un ordinamento degli studi di architettura volto a preparare ancora larchitetto integrale o se sia preferibile inseguire il più recente miraggio delle figure professionali «frammentate» che la diversificazione e la complessificazione dei saperi dellarchitetto induce a cercare di delineare, per tentare un approccio meno avventuroso alle cosiddette nuove «nicchie» di mercato. Certo è che lattuale esplosione di titoli differenziati – basti guardare agli innumerevoli e spesso incomprensibili corsi per laureati triennali comparsi in Italia dopo lautonomia concessa agli atenei, o ancora i tanti laureati magistrali che risultano alla fine non riconoscibili o virtualmente impotenti a operare professionalmente, causa la confusione che regna sui limiti delle rispettive competenze (architetti piuttosto che pianificatori o paesaggisti o, peggio ancora, conservatori) – non sembra aver portato né sollievo alla disoccupazione intellettuale degli architetti né la concretezza di una verificata corrispondenza alle attese dei settori produttivi potenzialmente interessati. E anche in questo caso, perdurando tanta incertezza, si profila allorizzonte non una riaffermazione del valore degli albi, intesi come registro qualificato di una comunità di intellettuali che si mettono al servizio dellinteresse generale (e della funzione, di conseguenza, degli Ordini, che ne sono i garanti), quanto piuttosto la loro progressiva perdita di importanza, se non la loro scomparsa (e quindi, ancora una volta, labolizione del valore legale dei titoli di studio), del tutto coerente con il percorso ultraliberistico che le istituzioni comunitarie hanno ormai da anni intrapreso e imposto, colpite dal sacro furore della ricerca di una astratta «concorrenza assoluta».
Gli Ordini degli architetti e la loro massima rappresentanza, il Consiglio Nazionale, devono ormai uscire dallambiguità e pronunciarsi apertamente. Tutti sanno, per esempio, quale disastro sia stato, ai fini di una più consapevole immissione sul mercato di professionisti preparati, il modello formativo cosiddetto 3+2: una crescita abnorme di sedi, corsi, titolazioni, costi (e bilanci in rosso), oltreché di figure professionali spaesate per la confusione di competenze generata. E ancora, allungamento del periodo di studio, impercettibile riduzione della mortalità studentesca, laureati e abilitati negli ultimi dieci anni in grande quantità (con voti di laurea peraltro gonfiati senza alcuna ragione, a fronte di un constatato e denunciato scadimento della preparazione universitaria). Un bilancio del tutto improponibile in un paese come lItalia, dove sgomitano senza prospettive centinaia di migliaia di altri «operatori» della progettazione. Ma tanti altri sono i problemi irrisolti e che richiedono una risposta ormai indilazionabile. In primo luogo, la scelta del momento selettivo. Se lo si sposta a dopo la laurea, urge una riforma degli esami di stato: le attuali quattro prove sono generiche e inutili, mentre il loro esito viene inficiato anche per le grandi differenze di valutazione che esprimono «geograficamente» le Commissioni in Italia.
Cè poi da affrontare, senza corporativismi da parte degli Ordini, il problema del finanziamento della sempre più maltrattata e impoverita università. Gli Atenei potranno partecipare alle gare per servizi di ingegneria e architettura (ora che le sentenze dellAlta Corte europea le hanno legittimate a farlo, non ci sarà tar che vi si potrà opporre). I pareri sul tema, da parte professionale, sono unanimi: togliere alle università la possibilità di scambiare attività professionale per ricerca. Ma, viste le loro condizioni e la rilevanza sociale della funzione che svolgono, non è preferibile cercare accordi di partnership?
Infine, la formazione permanente: quale e su quali argomenti? E poi, con chi ad assicurarla autorevolmente? Con lUniversità? Con il sistema delle imprese? A distanza o frontale? E chi deve gestire i corsi? Ma, soprattutto, tale formazione deve essere selettiva, ovvero portare coloro che non acquisiscono attraverso di essa i necessari crediti formativi alla esclusione dagli Albi, allontanandoli quindi dalla professione (ammesso, e non concesso, che lAntitrust non veda in ciò una indebita limitazione della concorrenza)?
Di questi tempi, cè un ritardo naturale tra formazione e mondo del lavoro che tende ad allungarsi. È la complessità delle conoscenze e delle pratiche che lo impone, per consentire al professionista di rispondere meglio alle esigenze che la società (le famiglie e le imprese) esprime. Ma oggi anche i cinque anni canonici di laurea sono un periodo di tempo che porta a cambiamenti eccezionali.
Chi decide, non perda quindi tempo, come si è già fatto nel riconoscere il fallimento della riforma universitaria nata dieci anno orsono. Piuttosto, chi studia (almeno, chi vuol fare larchitetto) non si preoccupi di prolungare la durata della sua preparazione per arricchirla. Ne avrà un beneficio professionale certamente più gratificante del solo possesso di un titolo di studio privo di valore.
Riccardo Bedrone
Presidente dellOrdine degli Architetti di Torino
Articoli recenti
- Firenze, 25 anni dopo: al paesaggio serve un progetto 12 Novembre 2025
- Paesaggi italiani contemporanei: adattamenti, contaminazioni, fragilità 12 Novembre 2025
- Essere paesaggisti in Italia: poca chiarezza, molti ostacoli 12 Novembre 2025
- Moda, lo spazio magico delle sfilate 11 Novembre 2025
- L’insostenibilità della parola sostenibilità. Non usiamola più! 10 Novembre 2025
- Tragico crollo nella Torre dei Conti: no a scelte frettolose 8 Novembre 2025
- Jean Prouvé double face: tra valorizzazione e conservazione 5 Novembre 2025
- Un grande, raffinato, magazzino per rivoluzionare l’agricoltura 5 Novembre 2025
- La migliore architettura: politicamente corretta, poche sorprese e archistar 5 Novembre 2025
- Vitra Campus, Balkrishna Doshi celebra il silenzio 5 Novembre 2025
- Il porto di Marsiglia ha il suo nuovo, vecchio, faro 4 Novembre 2025
- Impermeabilizzazione del terrazzo: Icobit Italia il tuo alleato 4 Novembre 2025
- Il Museo più grande, simboli e nazionalismo: l’Egitto si celebra 3 Novembre 2025
- Forma e relazioni in mostra alla Sapienza 3 Novembre 2025
Tag
Edizione mensile cartacea: 2002-2014. Edizione digitale: dal 2015.
Iscrizione al Tribunale di Torino n. 10213 del 24/09/2020 - ISSN 2284-1369
Fondatore: Carlo Olmo. Direttore: Michele Roda. Redazione: Cristiana Chiorino, Luigi Bartolomei, Ilaria La Corte, Milena Farina, Laura Milan, Arianna Panarella, Maria Paola Repellino, Veronica Rodenigo, Cecilia Rosa, Ubaldo Spina. Editore Delegato per The Architectural Post: Luca Gibello.
«Il Giornale dell’Architettura» è un marchio registrato e concesso in licenza da Società Editrice Allemandi a r.l. all’associazione culturale The Architectural Post; ilgiornaledellarchitettura.com è un Domain Name registrato e concesso in licenza da Società Editrice Allemandi a r.l. a The Architectural Post, editore della testata digitale, derivata e di proprietà di «Il Giornale dell’Architettura» fondato nell’anno 2002 dalla casa editrice Umberto Allemandi & C. S.p.A., oggi Società Editrice Allemandi a r.l.
L’archivio storico
CLICCA QUI ed effettua l’accesso per sfogliare tutti i nostri vecchi numeri in PDF.
© 2025 TheArchitecturalPost - Privacy - Informativa Cookies - Developed by Studioata